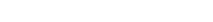Equity srl
35015 Bassano del Grappa, Via Corte 25
Tel: 04441496266 Fax: 04441491212
Cell: 3337228247
zanonsarajob@gmail.com

DIVORZIO ALL'ITALIANA
Qual è la differenza tra separazione e divorzio?
Come funzionano le procedure?
Qual è la differenza tra separazione consensuale e separazione giudiziale?
Quando può aversi la separazione con addebito?
Quali sono i costi quando la famiglia si rompe?
Quando è dovuto l'assegno di mantenimento?
È possibile un accordo pre-matrimoniale?
A chi vengono affidati i figli?
Con quali modalità vengono affidati i figli?
A quale dei due coniugi viene assegnata l'abitazione coniugale?
Quali sono le condizioni per poter ottenere il divorzio?
Si può avere un divorzio consensuale?
Quando può essere corrisposto l'assegno divorzile?
Quando si può richiedere una quota della liquidazione (TFR) dell'ex coniuge?
Queste e molte altre sono le questioni che deve affrontare chi si separa e non sempre il percorso risulta lineare. Le trasformazioni nella realtà matrimoniale, infatti, riservano degli ostacoli non facilmente risolvibili.
Tali eventi possono essere connesse a una difficoltà di comunicazione con sé o con il coniuge. A volte congruità d’intenti e di progetti, di valori e comportamenti, non vengono condivisi. C’è timore del conflitto, e si dialoga poco e male. Si ha voglia di lasciarsi tutto alle spalle, di chiudere, d’andare oltre, senza prendersi il giusto tempo.
Ma ogni cosa trova la sua giusta collocazione e una sua congruente risposta. Diamone alcune in questa sede:
Il matrimonio validamente contratto si può sciogliere per due sole cause: l’una naturale, ossia la morte di uno dei coniugi, l’altra legale, comunemente detta divorzio, per l’impossibilità, accertata con sentenza passata in giudicato, di mantenere ovvero di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione può essere legale (consensuale o giudiziale) o semplicemente "di fatto", ciò conseguente all'allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l'intervento di un giudice. La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio. I coniugi che si separano legalmente non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.
Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la legge 1.12.1970 n. 898 modificata dalle legge 1 agosto 1978 e dalla legge 6 marzo 1987 numero 74) viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio la dove sia stato celebrato con rito civile o la cessazione degli effetti civili, se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano.
I motivi della differenza risiedono nel fatto che il matrimonio celebrato con rito religioso non può essere sciolto dalla giurisdizione italiana, che interviene esclusivamente sugli effetti civili, poiché esso è di competenza della sola giurisdizione ecclesiastica. In entrambi i casi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili sono pronunciate dal giudice quando, dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione, si accerta che non può essere mantenuta o ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi per i motivi indicati dalla stessa legge dell'articolo 3.
La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di divorzio, vengono così a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale senza che essa determini però il venir meno dei rapporti
stabiliti in costanza del vincolo matrimoniale. Inoltre con la pronuncia del divorzio viene meno lo status di “coniuge”, ciò comporta l’estinzione dei doveri previsti dall’art. 143 c.c. e solo a questo punto il coniuge può scegliere di contrarre nuove nozze.
Secondo una parte della dottrina permane quella che viene definita “solidarietà post-coniugale”, basata sul fatto che i due soggetti divorziati, per un certo periodo di tempo, sono comunque stati marito e moglie e hanno attuato l’impegno di vita matrimoniale (BIANCA 2005,276) nello stesso senso anche GIUSTI- RUSSO 2009. Da ciò deriverebbero gli effetti di ordine patrimoniale a favore del coniuge divorziato quali il diritto all'assegno divorzile, il diritto di abitazione nella casa familiare, il diritto a prestazioni previdenziali e il diritto all'assegno successorio.
Per quanto concerne l’assegno divorzile, ai sensi dell’art.5, comma 6 della leg.div. con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno “ quando quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. L’indisponibilità dei mezzi adeguati è l’unica condizione posta dalla legge sul piano dell’an debeatur (se dovuto), è l’unica condizione, cioè, sulla cui base il giudice decide se riconoscere o meno il diritto a percepire un assegno divorzile vitalizio.
Premesso ciò, l’adeguatezza dovrebbe essere valutata con riferimento ad uno standard medio di vita dignitosa (GAZZONI 2004,394). La giurisprudenza e la dottrina maggioritarie rapportano, infatti, l’adeguatezza al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. 7 maggio 1998, n.4617; Cass.12 luglio 2007, n.15610). La giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione ritiene che il giudice deve tener conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e altresì del tenore che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale (Cass. 2 luglio 2007, n.14965). Ai fini di tale accertamento, il tenore di vita precedente viene desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalla disponibilità patrimoniale.

La Corte di Cassazione ha stabilito che nella determinazione dell’importo dell’assegno divorzile occorre tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l’assegno, anche se successivi alla cessazione della convivenza, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio e trovino radice nell’attività all’epoca svolta durante il matrimonio e/o nel tipo di qualificazione professionale e/o nella collocazione sociale dell’onerato.
Sussiste in capo ai coniugi l’onere di attivarsi valorizzando la propria capacità lavorativa sì da potersi procurare i mezzi adeguati per vivere.