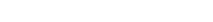Amministrazioni Condominiali DOTTOR GIORGIO SALVO
20098 San Giuliano Milanese, Via Mazzini 24
condominio.salvo@gmail.com
Cos'è il Plain Language
Il Plain Language non è altro che un linguaggio utilizzato per comunicare un messaggio nel modo più efficace e semplice possibile.
Per fare questo non solo colui che scrive deve selezionare le informazioni che intende fornire al destinatario eliminando tutti gli elementi inutili, ma deve anche costruire il testo in maniera ordinata e schematica per facilitare il reperimento delle informazioni.
Scrivere in Plain Language è tutt’altro che facile perché oltre a curare schema del testo e scelta delle informazioni è fondamentale la scelta delle parole che compongono il messaggio.
Deve infatti trattarsi di parole di uso comune utilizzate nella conversazione quotidiana, tenendo ovviamente ben presente che le differenze tra scrittura e oralità non potranno mai essere sovrapposte: andrebbero quindi evitate parole desuete, gergali e i tecnicismi non necessari.
Andrebbero insomma evitati tutti gli elementi che rendono difficoltosa la comprensione di un testo specialmente se questo è indirizzato a soggetti che non hanno dimestichezza con il linguaggio tecnico ma che per necessità devono accedere alle informazioni contenute all’interno del testo.
Si tratta di scelte che dovranno necessariamente tenere conto del destinatario, al quale si vuole permettere di giungere il più facilmente e velocemente possibile al messaggio contenuto nel testo.
Come detto da Daniele Fortis, nel suo saggio “Il Plain Language. Quando le istituzioni si fanno capire”, il Plain Language non è altro che “la linea retta che costituisce la via più breve fra due punti: l’emittente e il destinatario del messaggio”.
DOVE SI DOVREBBE APPLICARE IL PLAIN LANGUAGE?
Gli accorgimenti sopra elencati per la realizzazione di un testo chiaro possono apparire scontati: se un soggetto scrive un testo contenente un messaggio, il suo obbiettivo dovrebbe essere quello di farsi capire dal destinatario. Ma non sempre è così, anzi sono diversi gli ambiti in cui ci sarebbe un gran bisogno di mettere in pratica le regole di buona scrittura enunciate dagli studiosi del Plain Language. Si va dalle istruzioni per l’utilizzo di elettrodomestici agli importantissimi foglietti illustrativi dei medicinali, passando persino per le bollette per la fornitura di servizi come luce e gas: ambiti appartenenti alla vita quotidiana che toccano ogni persona, indipendentemente dal suo grado di istruzione.
A fornire il miglior esempio di “cattiva comunicazione”, il materiale prodotto dalla Pubblica Amministrazione ed indirizzato ai cittadini: leggendo i testi in questione ci si può rendere conto di come la maggior parte delle volte, se non la quasi totalità, tutti gli accorgimenti sopra enunciati per scrivere un testo comprensibile siano ignorati. Un comune cittadino che si trovi a dover avere a che fare con un documento pubblico, per estrapolarne informazioni necessarie per esercitare un diritto o per adempiere ad un dovere, deve fare i conti con testi inutilmente prolissi pieni di parole antiquate, termini tecnici il più delle volte evitabili, neologismi, sigle non spiegate e frasi lunghe e verbose. Senza considerare il fatto che il più delle volte il testo è costruito con una scarsa selezione delle informazioni, in modo tale da impedire al lettore di capire quali siano le informazioni fondamentali e quali quelle di importanza secondaria. I testi scritti dalla Pubblica amministrazione insomma non sempre tengono conto del fatto che non tutti hanno un livello di istruzione tale da poter comprendere un linguaggio tecnico, ma ciò non significa che i cittadini debbano essere discriminati per questo. E’ talmente tanta la distanza tra il linguaggio comune e quello adottato dalla Pubblica Amministrazione che il linguaggio appena descritto ha assunto un nome tutto suo, “burocratese”.
Altro ambito in cui è fortemente avvertita la necessità di adottare le regole dello “scriver chiaro” è quello relativo a contratti per adesione e prospetti informativi di banche e assicurazioni. Tali documenti infatti non fanno che accentuare la distanza tra l’istituto emittente il contratto e il consumatore che, oltre a dover accettare in toto un contratto prestampato, nella maggior parte dei casi si trova dover fare i conti con termini tecnici non spiegati, rimandi a testi di legge non presenti all’interno del documento e sconosciuti al consumatore, clausole incomprensibili. A queste condizioni il consumatore è di fatto messo nella situazione di sottoscrivere il contratto senza capirne il contenuto.
Ancora più grave è infine, è il disagio provocato nella quasi totalità dei cittadini dal linguaggio adottato dai testi normativi. Ambito in cui, per definizione e secondo un principio sancito anche dall’ordinamento italiano (la legge non ammette ignoranza), il contenuto delle norme dovrebbe essere compreso e applicato da tutti i cittadini sia per adempiere ai doveri previsti dal sistema giuridico che per esercitare i propri diritti. Il punto sta nel fatto che anche le leggi, come i documenti redatti dalla Pubblica Amministrazione, non sono indirizzati solo ai giuristi ma alla totalità dei cittadini che devono essere messi nelle condizioni di capire le regole su cui si basa la società in cui vivono.